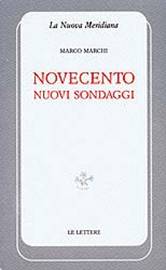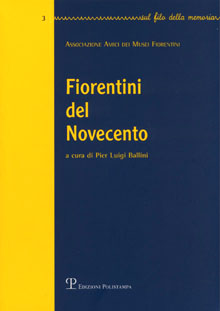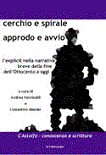|
Marco Marchi, Novecento. Nuovi sondaggi, Le Lettere, 2004
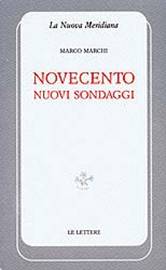
A
dieci anni di distanza dai Sondaggi novecenteschi, questa nuova opera di Marco
Marchi raccoglie altri tredici saggi su altrettanti protagonisti del secolo
appena scorso. E così, insieme ai «grandi» come
Svevo, Montale, Pasolini e Palazzeschi, ritroviamo Loria, Baldacci, Tozzi, Papini, Luzi, Landolfi e tutti i
personaggi che gravitavano intorno alla rivista «Il Frontespizio» e alla
«Antologia Vieusseux». Una ricostruzione del Novecento che non lascia fuori
un altro «grande» di quel secolo, il melodramma, quello «scriver cantando»
che potrà sedurre o respingere poeti e scrittori, ma che a
ogni modo li influenzerà e si insinuerà tra i loro versi e le loro
righe.
http://www.lelettere.it
|
|

Andrea Vannicelli, La tentazione del racconto: le novelle del primo Papini tra
simbolismo e futurismo (1894-1914), Cesati, 2004
 Il panorama della letteratura
italiana del primo Novecento presenta ancora, pur dopo le varie e complesse
esplorazioni che la storiografia contemporanea vi ha condotto, numerose zone
d’ombra: su una di esse, le novelle del giovane
Papini, l’autore ha voluto proporre un’indagine minuziosa e ricca di dati, ma
al tempo stesso informata da un’interpretazione globale. Giovanni Papini
(1881-1956), lo scrittore italiano che in vita conobbe affermazioni e
contrasti, ha subíto dopo la morte molto spesso un
disconoscimento della sua statura d’artista e di uomo. A più di quarant’anni
dalla sua scomparsa, la sua figura torna ad imporsi come quella di uno dei
grandi protagonisti della letteratura italiana della
prima metà del Novecento. Il panorama della letteratura
italiana del primo Novecento presenta ancora, pur dopo le varie e complesse
esplorazioni che la storiografia contemporanea vi ha condotto, numerose zone
d’ombra: su una di esse, le novelle del giovane
Papini, l’autore ha voluto proporre un’indagine minuziosa e ricca di dati, ma
al tempo stesso informata da un’interpretazione globale. Giovanni Papini
(1881-1956), lo scrittore italiano che in vita conobbe affermazioni e
contrasti, ha subíto dopo la morte molto spesso un
disconoscimento della sua statura d’artista e di uomo. A più di quarant’anni
dalla sua scomparsa, la sua figura torna ad imporsi come quella di uno dei
grandi protagonisti della letteratura italiana della
prima metà del Novecento.
(continua)
|
|

Paola
Italia, Il pellegrino
appassionato. Savinio scrittore. 1915-1925, Sellerio, 2004
 La ricostruzione di questa avventura - completa di fonti e particolari,
minuziosa fino alla cronaca quasi quotidiana - ci racconta un Savinio operosissimo,
che intanto si prepara meticolosamente con un curricolo da studente
autodidatta all'illusione di elegante facilità della sua prosa laboriosamente
raggiunta, e con tratti insospettabili: quando per esempio si scopre che al
suo arrivo in Italia Savinio ha una padronanza della lingua italiana meno che
scolastica e inizialmente la traduce dal francese con - dice egli stesso -
'somma fatica'. Che scrive per riviste e rivistine con
entusiasmi e delusioni, fino ai primi riconoscimenti e successi. Sullo
sfondo l'infaticabile opera di consumato 'agente letterario' del fratello
Giorgio de Chirico che contemporaneamente avvia il suo straordinario genio
pittorico; il sodalizio ferrarese col fratello, e Carrà, e De Pisis, in cui
s'inventa l'arte metafisica; e la viva stagione della nuova letteratura
italiana, tra Milano Firenze e Roma, di Papini, Soffici, Prezzolini,
Cardarelli, Bontempelli, troppo a lungo sottovalutata, e più breve di quanto si immagini, per via dell'avvento del Fascismo.
"Inutile dire - spiegava Savinio - che, carpito il potere, Mussolini non
si ricordò più di noi. Cominciò allora quella sorda avversione al fascismo
degli uomini di mente poetica e artistica, che svuotò il fascismo di ogni contenuto spirituale e diventò così una delle
cause meno appariscenti, ma più profonde della sua morte". Con
un'Appendice di testi inediti. La ricostruzione di questa avventura - completa di fonti e particolari,
minuziosa fino alla cronaca quasi quotidiana - ci racconta un Savinio operosissimo,
che intanto si prepara meticolosamente con un curricolo da studente
autodidatta all'illusione di elegante facilità della sua prosa laboriosamente
raggiunta, e con tratti insospettabili: quando per esempio si scopre che al
suo arrivo in Italia Savinio ha una padronanza della lingua italiana meno che
scolastica e inizialmente la traduce dal francese con - dice egli stesso -
'somma fatica'. Che scrive per riviste e rivistine con
entusiasmi e delusioni, fino ai primi riconoscimenti e successi. Sullo
sfondo l'infaticabile opera di consumato 'agente letterario' del fratello
Giorgio de Chirico che contemporaneamente avvia il suo straordinario genio
pittorico; il sodalizio ferrarese col fratello, e Carrà, e De Pisis, in cui
s'inventa l'arte metafisica; e la viva stagione della nuova letteratura
italiana, tra Milano Firenze e Roma, di Papini, Soffici, Prezzolini,
Cardarelli, Bontempelli, troppo a lungo sottovalutata, e più breve di quanto si immagini, per via dell'avvento del Fascismo.
"Inutile dire - spiegava Savinio - che, carpito il potere, Mussolini non
si ricordò più di noi. Cominciò allora quella sorda avversione al fascismo
degli uomini di mente poetica e artistica, che svuotò il fascismo di ogni contenuto spirituale e diventò così una delle
cause meno appariscenti, ma più profonde della sua morte". Con
un'Appendice di testi inediti.
Indice:
Premessa;
Capitolo 1. Un''officina ferrarese';
Capitolo 2. Un cantiere letterario a Salonicco;
Capitolo 3. Il ritorno dell'Argonauta;
Capitolo 4. Per una 'filosofia delle arti': "Valori plastici";
Capitolo 5. Sotto il segno di Papini: "La Vraie Italie";
Capitolo 6. Savinio 'rondista' e l'ironia leopardiana;
Capitolo 7. Un romanzo schopenhaueriano: "La casa ispirata";
Capitolo 8. Un romanzo weiningeriano: "Avventure e considerazioni di Innocenzo Paleari";
Capitolo 9. La 'poetica della memoria': "Tragedia
dell'infanzia" e "Sul dorso del Centauro";
Capitolo 10. Savinio e il fascismo: il "Nuovo Paese" e il
"Corriere Italiano";

|
|
Pier
Luigi Ballini (a cura di), Fiorentini
del Novecento, Polistampa, 2004
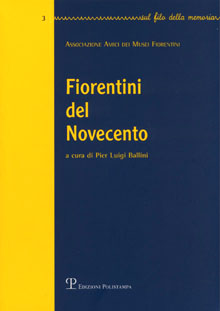 “Il Novecento a Firenze è una
pagina di grande rilievo nella storia dell’Italia
contemporanea. I personaggi che hanno animato e reso, per tanti aspetti,
inconfondibile la storia di questa straordinaria città hanno
lasciato segni profondi, ben al di là dei suoi confini, spesso al di là di
quelli dello stesso paese. I profili biografici consentono di conoscere non
soltanto vita, attività, opere di questi Fiorentini del Novecento ma
anche di ricostruire aspetti e vicende del secolo passato. Offrono
indicazioni e percorsi di ricerca, motivi di riflessione” (Dall’
Introduzione di Cesare Angotti). “Il Novecento a Firenze è una
pagina di grande rilievo nella storia dell’Italia
contemporanea. I personaggi che hanno animato e reso, per tanti aspetti,
inconfondibile la storia di questa straordinaria città hanno
lasciato segni profondi, ben al di là dei suoi confini, spesso al di là di
quelli dello stesso paese. I profili biografici consentono di conoscere non
soltanto vita, attività, opere di questi Fiorentini del Novecento ma
anche di ricostruire aspetti e vicende del secolo passato. Offrono
indicazioni e percorsi di ricerca, motivi di riflessione” (Dall’
Introduzione di Cesare Angotti).
In questo volume sono presentati: Pietro Annigoni, Ernesto Balducci, Piero
Bargellini, Gino Bechi, Umberto e Nathan Cassuto, Edoardo Detti, Leo Samuele
Olschki, Giovanni Papini, Pietro Porcinai, Carlo Ludovico Ragghianti,
Ardengo Soffici, Attilio e Enrico Vallecchi.
Scritti di Benedetto Annigoni, Sandro Rogari, Bruna Bocchini Camaiani, Pier
Luigi Ballini, Luciano Alberti, Ida Zatelli, Mariella Zoppi, Pier Francesco
Listri, Giorgio Luti, Luigi Zangheri, Alberto Busignani.
Presentazione di Carla Guiducci Bonanni.
www.polistampa.com
|
|

Angelo Comastri, Dov'è il tuo Dio? Storie di conversioni nel
XX secolo, Edizioni San Paolo, 2003
 Le storie di Paolo di Tarso, di Agostino di Ippona, dei grandi convertiti dei secoli
antichi ancora oggi riempiono di stupore. Ai contemporanei, tuttavia,
sembrano storie di un passato lontano, come se Cristo non avesse più la forza
di chiamare e di attrarre. Sua Eccellenza Angelo Comastri dimostra, invece,
in questo volume che la voce di Cristo è ancora capace di procurarsi ascolto,
di risuonare nei cuori, nonostante i pregiudizi e l'ostilità. Adolfo Retté,
André Frossard, Giovanni Papini,
Edith Stein, Eugenio Zolli, Sergej Kourdakov e Pietro Cavallero sono uomini
del 1900. Diversi per origine, formazione e professione essi credevano di
portare avanti un loro progetto di vita quando una voce potente ordinò loro
di abbandonare la loro casa per avviarsi verso una terra nuova. Come Abramo e
come Paolo essi furono quasi costretti ad obbedire. Iniziarono una vita
nuova, una vita di fede, di speranza e di carità che non mortificava il loro
talento ma riscaldava il cuore ed apriva nuove prospettive. I racconti di
conversione di sua Eccellenza Comastri non hanno per scopo la gloria degli
uomini. Essi testimoniano che Cristo è vivo e continua a chiamare alla sua
sequela. La sua compagnia calma le tempeste, libera dall'angoscia e dall'oppressione. Le storie di Paolo di Tarso, di Agostino di Ippona, dei grandi convertiti dei secoli
antichi ancora oggi riempiono di stupore. Ai contemporanei, tuttavia,
sembrano storie di un passato lontano, come se Cristo non avesse più la forza
di chiamare e di attrarre. Sua Eccellenza Angelo Comastri dimostra, invece,
in questo volume che la voce di Cristo è ancora capace di procurarsi ascolto,
di risuonare nei cuori, nonostante i pregiudizi e l'ostilità. Adolfo Retté,
André Frossard, Giovanni Papini,
Edith Stein, Eugenio Zolli, Sergej Kourdakov e Pietro Cavallero sono uomini
del 1900. Diversi per origine, formazione e professione essi credevano di
portare avanti un loro progetto di vita quando una voce potente ordinò loro
di abbandonare la loro casa per avviarsi verso una terra nuova. Come Abramo e
come Paolo essi furono quasi costretti ad obbedire. Iniziarono una vita
nuova, una vita di fede, di speranza e di carità che non mortificava il loro
talento ma riscaldava il cuore ed apriva nuove prospettive. I racconti di
conversione di sua Eccellenza Comastri non hanno per scopo la gloria degli
uomini. Essi testimoniano che Cristo è vivo e continua a chiamare alla sua
sequela. La sua compagnia calma le tempeste, libera dall'angoscia e dall'oppressione.
|
|

Alberto Cadioli, Letterati editori, Net, 2003
 Temuto come minaccia alla
creatività, ma ambìto come fonte privilegiata di guadagno, il rapporto con l'editoria
rappresenta un momento centrale nell'esperienza dei letterati italiani tra
Otto e Novecento. La sua importanza, però, si rivela interamente solo quando lo si osserva con uno sguardo nuovo, capace di scorgere
nell'attività editoriale di molti scrittori e critici la ricerca di un
progetto culturale e letterario. E' con questo sguardo che Alberto Cadioli
prende in esame alcuni tra i più significativi
"letterati editori" del nostro secolo: Papini e Prezzolini, con le edizioni della Voce: Carocci e Bonsanti,
con le Edizioni di Solaria e la Collezione di Letteratura che hanno fatto
conoscere i grandi scrittori contemporanei: Luigi Rusca, con le edizioni
economiche della "Bur" negli anni cinquanta. E
ancora Debenedetti e Calvino che al Saggiatore e all'Einaudi hanno
trasformato il lavoro editoriale in un intervento "militante" per
affermare un preciso modello di letteratura. Temuto come minaccia alla
creatività, ma ambìto come fonte privilegiata di guadagno, il rapporto con l'editoria
rappresenta un momento centrale nell'esperienza dei letterati italiani tra
Otto e Novecento. La sua importanza, però, si rivela interamente solo quando lo si osserva con uno sguardo nuovo, capace di scorgere
nell'attività editoriale di molti scrittori e critici la ricerca di un
progetto culturale e letterario. E' con questo sguardo che Alberto Cadioli
prende in esame alcuni tra i più significativi
"letterati editori" del nostro secolo: Papini e Prezzolini, con le edizioni della Voce: Carocci e Bonsanti,
con le Edizioni di Solaria e la Collezione di Letteratura che hanno fatto
conoscere i grandi scrittori contemporanei: Luigi Rusca, con le edizioni
economiche della "Bur" negli anni cinquanta. E
ancora Debenedetti e Calvino che al Saggiatore e all'Einaudi hanno
trasformato il lavoro editoriale in un intervento "militante" per
affermare un preciso modello di letteratura.
|
|

Mario
Isnenghi, Il mito della Grande Guerra,
Il Mulino, 2003
 Qui presentato nella quinta
edizione questo volume, fortemente innovativo per
tesi, documentazione e metodo, ha segnato uno spartiacque negli studi sulla
prima guerra mondiale. Le riviste dell'età della "Voce", i fogli
interventisti, i diari di trincea e la letteratura sulla guerra: rileggendo
questa sterminata produzione Isnenghi ha ricostruito l'atteggiamento di una intera generazione di intellettuali italiani nei
confronti dell'intervento e poi dell'esperienza bellica. Da Marinetti a Papini, da Prezzolini a Gadda, da
Soffici a Jahier, Serra, Malaparte, Borgese, d'Annunzio, la guerra si
configura di volta in volta come occasione rigeneratrice per l'individuo e la
società, come veicolo di protesta o, al contrario,
antidoto alla lotta di classe. Le molte facce del mito della Grande Guerra
compongono in queste pagine uno spaccato di storia mentale, sociale, politica
dell'Italia nel passaggio dalla politica delle élites alla società di massa. Qui presentato nella quinta
edizione questo volume, fortemente innovativo per
tesi, documentazione e metodo, ha segnato uno spartiacque negli studi sulla
prima guerra mondiale. Le riviste dell'età della "Voce", i fogli
interventisti, i diari di trincea e la letteratura sulla guerra: rileggendo
questa sterminata produzione Isnenghi ha ricostruito l'atteggiamento di una intera generazione di intellettuali italiani nei
confronti dell'intervento e poi dell'esperienza bellica. Da Marinetti a Papini, da Prezzolini a Gadda, da
Soffici a Jahier, Serra, Malaparte, Borgese, d'Annunzio, la guerra si
configura di volta in volta come occasione rigeneratrice per l'individuo e la
società, come veicolo di protesta o, al contrario,
antidoto alla lotta di classe. Le molte facce del mito della Grande Guerra
compongono in queste pagine uno spaccato di storia mentale, sociale, politica
dell'Italia nel passaggio dalla politica delle élites alla società di massa.
|
|

Piero
Gobetti, Carteggio 1918-1922,
Einaudi, 2003
 Piero Gobetti (1901-1926) occupa
una posizione atipica nella storia del pensiero politico italiano. Padre dell'antifascismo
intransigente, è stato a lungo, e in una certa misura è tuttora, oggetto di
un 'uso pubblico': rivendicato come eredità
simbolica da liberalsocialisti e azionisti, comunisti, liberali, sinistra
democratica da una parte; contestato per il suo liberalismo rivoluzionario
dall'altra. Piero Gobetti (1901-1926) occupa
una posizione atipica nella storia del pensiero politico italiano. Padre dell'antifascismo
intransigente, è stato a lungo, e in una certa misura è tuttora, oggetto di
un 'uso pubblico': rivendicato come eredità
simbolica da liberalsocialisti e azionisti, comunisti, liberali, sinistra
democratica da una parte; contestato per il suo liberalismo rivoluzionario
dall'altra.
Meno esplorato è stato il suo pensiero dal punto di vista storico, che invece
ne può fornire le chiavi di lettura: un'esperienza maturata in meno di otto anni, nel periodo culminante della crisi italiana
ed europea del primo dopoguerra, dovrebbe essere letta nel suo farsi e nel
contesto in cui si è definita. La pubblicazione integrale dei carteggi
gobettiani fornisce uno strumento essenziale a tale scopo: già iniziata con
l'edizione della corrispondenza con Ada Prospero, prosegue ora con lo scambio
epistolare con personaggi di primo piano della cultura italiana, da Croce,
Gentile, Salvemini, Einaudi a Prezzolini, Papini, Soffici, Carrà e con i coetanei Santino Caramella, Carlo
Levi, Natalino Sapegno. A differenza delle lettere alla fidanzata, quelle
dirette ai maestri e agli amici non fanno alcuna concessione al privato, e
costituiscono la trama di un'intensissima attività culturale. Ricostituiti in
un'unica sequenza cronologica, i carteggi sopravvissuti alle inevitabili
dispersioni presentano nuove interrelazioni e colmano i vuoti d'informazione,
per esempio quello sul periodo che intercorre tra la fine di "Energie
Nove" e l'inizio della "Rivoluzione
Liberale", ampiamente documentato in questo volume. Da tale
intreccio risulta una sorta di autobiografia, nella
quale appare con evidenza l''equivoco generazionale' che ha segnato la
formazione di Gobetti, rendendo piú drammatica la resa dei conti con la
generazione dei fratelli della "Voce", all'avvento del fascismo.
L'edizione è corredata dall''Introduzione' della curatrice Ersilia
Alessandrone Perona, che ha aggiunto un''Appendice' di documenti inediti o
adespoti collegati alle lettere e schede sui novanta corrispondenti di
Gobetti presenti in questo volume.
|
|

Paolo
Casini, Alle origini del Novecento. «Leonardo»,
1903-1907, Il Mulino, 2002
 I venticinque fascicoli del
periodico giovanile d'avanguardia «Leonardo»,
pubblicati tra il 1903 e il 1907, continuano a sollecitare la critica
storica, letteraria, ideologica di varia tendenza. Della Florentine band
of Leonardists, come la definì William James, fecero parte, oltre a Papini
e Prezzolini, artisti come Spadini, De Carolis e Costetti, scrittori come
Borgese e Cecchi, filosofi come Vailati, Calderoni, Amendola. Questo saggio
offre una via d'accesso al caleidoscopio di correnti ideologiche e pulsioni
iconoclaste che si alternarono nelle pagine fino all'adesione al pragmatismo di
James, in occasione del Congresso di psicologia tenuto a Roma nell'aprile del
1905; scelta che segnò il culmine della parabola del «Leonardo»
e l'inizio del suo declino, sullo sfondo di un aspro conflitto tra
neoidealisti e pragmatisti pro e contro le nuove tendenze della
psicologia sperimentale. Gli slanci, le infatuazioni, le cadute, le prese di
posizione, i manifesti, le formule e le svolte ideologiche, le scelte
fideistiche dei protagonisti sono colti in un panorama d'insieme come momenti
di una storia scritta a più mani da intellettuali ventenni, impegnati
nell'avventurosa ricerca di una propria identità. A
distanza di un secolo, il segno di contraddizione impresso nelle pagine del
«Leonardo», avversato dai benpensanti, accolto con imbarazzo dai posteri,
appare paradossalmente sottratto al dominio dell'effimero e all'usura del
tempo. I venticinque fascicoli del
periodico giovanile d'avanguardia «Leonardo»,
pubblicati tra il 1903 e il 1907, continuano a sollecitare la critica
storica, letteraria, ideologica di varia tendenza. Della Florentine band
of Leonardists, come la definì William James, fecero parte, oltre a Papini
e Prezzolini, artisti come Spadini, De Carolis e Costetti, scrittori come
Borgese e Cecchi, filosofi come Vailati, Calderoni, Amendola. Questo saggio
offre una via d'accesso al caleidoscopio di correnti ideologiche e pulsioni
iconoclaste che si alternarono nelle pagine fino all'adesione al pragmatismo di
James, in occasione del Congresso di psicologia tenuto a Roma nell'aprile del
1905; scelta che segnò il culmine della parabola del «Leonardo»
e l'inizio del suo declino, sullo sfondo di un aspro conflitto tra
neoidealisti e pragmatisti pro e contro le nuove tendenze della
psicologia sperimentale. Gli slanci, le infatuazioni, le cadute, le prese di
posizione, i manifesti, le formule e le svolte ideologiche, le scelte
fideistiche dei protagonisti sono colti in un panorama d'insieme come momenti
di una storia scritta a più mani da intellettuali ventenni, impegnati
nell'avventurosa ricerca di una propria identità. A
distanza di un secolo, il segno di contraddizione impresso nelle pagine del
«Leonardo», avversato dai benpensanti, accolto con imbarazzo dai posteri,
appare paradossalmente sottratto al dominio dell'effimero e all'usura del
tempo.
|
|

AA.VV.Cerchio e spirale. Approdo e avvio. L’explicit
nella narrativa breve dalla fine dell’Ottocento a
oggi,L'Astolfo, 2002 Atti del convegno internazionale tenuto all’Université catholique de
Louvain-la-Neuve, Ottobre 1999
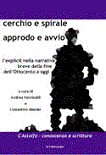 Questa miscellanea riunisce
studi di italianisti olandesi, belgi, italiani e
svizzeri sull’explicit nella narrativa breve dall’Ottocento a oggi. Accanto a
studi teorici e generali vi si trovano saggi su d’Annunzio, Jahier, Papini,
Primo Levi, Calvino, Parise, Bonaviri e Tabucchi. Fino a
oggi gli studi dedicati agli incipit sono stati molti, quelli che si sono
soffermati sulle chiuse pochi, come se la fine fosse conseguenza scontata di
ciò che la precede. È sufficiente leggere gli explicit
delle novelle di Verga per comprendere come la fine sia tutt’altro che
limine prevedibile. Nella narrativa breve di consumo si preferiva (e si
preferisce) una fine che conferma idealmente valori
esposti in una cornice o che è punto d’arrivo di una struttura teleologica.
Più tardi sono comparsi anche testi a spirale e ad avvio, le cui chiuse si
prolungano in un aldilà di lettura incerto, non definitivo.
Spirale e cerchio, approdo e avvio sono nozioni complesse e contraddittorie
su cui gli autori di questa miscellanea cercano di riflettere. Questa miscellanea riunisce
studi di italianisti olandesi, belgi, italiani e
svizzeri sull’explicit nella narrativa breve dall’Ottocento a oggi. Accanto a
studi teorici e generali vi si trovano saggi su d’Annunzio, Jahier, Papini,
Primo Levi, Calvino, Parise, Bonaviri e Tabucchi. Fino a
oggi gli studi dedicati agli incipit sono stati molti, quelli che si sono
soffermati sulle chiuse pochi, come se la fine fosse conseguenza scontata di
ciò che la precede. È sufficiente leggere gli explicit
delle novelle di Verga per comprendere come la fine sia tutt’altro che
limine prevedibile. Nella narrativa breve di consumo si preferiva (e si
preferisce) una fine che conferma idealmente valori
esposti in una cornice o che è punto d’arrivo di una struttura teleologica.
Più tardi sono comparsi anche testi a spirale e ad avvio, le cui chiuse si
prolungano in un aldilà di lettura incerto, non definitivo.
Spirale e cerchio, approdo e avvio sono nozioni complesse e contraddittorie
su cui gli autori di questa miscellanea cercano di riflettere.
Contiene: Andrea
Vannicelli, Gli explicit nelle novelle del primo Papini, tra liberty e futurismo
Nei
racconti del Tragico quotidiano, pubblicati da Papini nel 1906, non
mancano le concessioni alla moda letteraria dell’epoca, e non manca neppure
qualche ingenuità, che volentieri perdoneremo al giovane autore. Ci sono una
serie di explicit molto eleganti, di un’eleganza
liberty. Ecco come termina per esempio I consigli di Amleto,
un lungo monologo di un personaggio molto caro ai simbolisti : «Ma ecco
che all’ora dell’aspettazione succede quella dell’impazienza.
La nave ondeggia e si scuote sullo specchio delle acque e fa gemer gli
ormeggi che la ritengono presso terra – il cavallo scalpita e freme e
protende il muso in avanti verso il prato che odora, verso il campo che
mareggia.» Un certo estetismo, di marca dannunziana,
non è assente da queste righe, che tradiscono una tendenza ad inserire
metafore auliche nel corso del dettato narrativo. La novella fu d’altronde
prepubblicata nel 1904 su «Hermes», una rivista che prediligeva il
dannunzianesimo.
|
|

Barna
Occhini, Lettera a te, Le Lettere, 2002
 Una lunga lettera d'amore alla
donna amata, da poco scomparsa, un lungo colloquio, un
ultimo tenero incontro per raccontarsi la vita trascorsa. Potrebbe essere una
storia come tante ce ne sono e ce ne saranno: di amore
e di morte, di affetti spezzati anzitempo e di affanni senza speranza, se la
penna di chi scrive non fosse quella di Barna Occhini, scrittore, saggista,
storico dell'arte, che trasforma questa lunga Lettera a te in un
romanzo nel quale i protagonisti rispondono ai nomi di Giovanni Papini
con la moglie Giacinta, Viola Papini Paszkowski, Ilaria Occhini, Ardengo
Soffici, che nel testo compaiono semplicemente come il padre, la madre, la
sorella, la figlia, l'amico del padre. Nessun nome proprio, solo il grado di
parentela o di amicizia rispetto alla destinataria
di questa Lettera, Gioconda Papini, donna la cui eccezionale bellezza è
fermata in tante fotografie (che arricchiscono questo volume), e da un bel
ritratto fattole da Primo Conti. Un solo nome compare, e una volta soltanto:
Gioconda, ultima parola-invocazione accorata in questo testo rimasto inedito
per quasi mezzo secolo e che Simonetta Bartolini ha recuperato e curato per
la stampa. Un romanzo che è un atto d'amore e insieme un documento storico: i
protagonisti hanno infatti un posto importante nella
nostra storia letteraria e politica. Una lunga lettera d'amore alla
donna amata, da poco scomparsa, un lungo colloquio, un
ultimo tenero incontro per raccontarsi la vita trascorsa. Potrebbe essere una
storia come tante ce ne sono e ce ne saranno: di amore
e di morte, di affetti spezzati anzitempo e di affanni senza speranza, se la
penna di chi scrive non fosse quella di Barna Occhini, scrittore, saggista,
storico dell'arte, che trasforma questa lunga Lettera a te in un
romanzo nel quale i protagonisti rispondono ai nomi di Giovanni Papini
con la moglie Giacinta, Viola Papini Paszkowski, Ilaria Occhini, Ardengo
Soffici, che nel testo compaiono semplicemente come il padre, la madre, la
sorella, la figlia, l'amico del padre. Nessun nome proprio, solo il grado di
parentela o di amicizia rispetto alla destinataria
di questa Lettera, Gioconda Papini, donna la cui eccezionale bellezza è
fermata in tante fotografie (che arricchiscono questo volume), e da un bel
ritratto fattole da Primo Conti. Un solo nome compare, e una volta soltanto:
Gioconda, ultima parola-invocazione accorata in questo testo rimasto inedito
per quasi mezzo secolo e che Simonetta Bartolini ha recuperato e curato per
la stampa. Un romanzo che è un atto d'amore e insieme un documento storico: i
protagonisti hanno infatti un posto importante nella
nostra storia letteraria e politica.
|
|

Opere precedenti al 2002
|
|
|